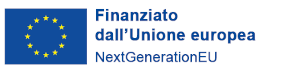Guida alla consultazione
La sezione iniziale della scheda fornisce per ogni lemma:
- l’elenco dei Correlati, a loro volta oggetto di schede raggiungibili; la categoria, ampiamente intesa, include corradicali, alterati, verbi pronominali, mentre non sono considerate le varianti di significato affine
- la Classe lessicale
- il numero di Occorrenze totali e di Occorrenze per opera; sono segnalate, quando presenti, le Occorrenze in citazione o in autocitazione
- la Diacronia delle opere che registrano occorrenze del lemma. Se un racconto o un saggio sono stati pubblicati in rivista e successivamente raccolti in volume, si indica la data della prima apparizione a stampa, seguita dalla data del volume in parentesi quadra.
A questo punto il lemma viene analizzato a partire dai suoi rapporti con altri termini entro la frase, così da rendere visibili gli accostamenti che determinano il significato (argomenti), o che lo modificano (modificatori). Il campo Relazioni e significati prevede dunque cinque possibili campi:
- Argomenti
- Argomento di
- Modificatori
- Modificatore di
- Nessuna relazione.
Alla base della classificazione qui proposta è la distinzione tra concetti relazionali, o insaturi, che disegnano relazioni; e concetti classificatori, o saturi, che entrano in queste relazioni come termini passivi. Per ciascun lemma relazionale (tipicamente, i verbi e i nomi che classificano processi o proprietà) si indicheranno dunque gli Argomenti che ne completano il significato. Per esempio, il lemma torcere, nel segmento «torcere la bocca», ha come argomento bocca. A loro volta, i lemmi classificatori (tipicamente, i nomi che designano oggetti o masse di sostanza) sono accompagnati dalla rubrica Argomento di. Per esempio il lemma incantamento, in «ha fatto un incantamento», è argomento di ha fatto. Vengono quindi segnalati i Modificatori, o elementi che modificano il significato (il concetto di modificatore è impiegato in senso ampio e comprende, oltre ad avverbi, aggettivi e apposizioni, anche complementi – ivi inclusi i complementi predicativi –, similitudini, e frasi relative). Per esempio il lemma rauco, in «voce leggermente rauca», avrà come modificatore leggermente. All’inverso, si segnalano le voci che è il lemma stesso a modificare (Modificatore di). Per esempio, il lemma miracolosamente, in «ci aveva miracolosamente risparmiati», è modificatore di ci aveva risparmiati.
Dunque, il valore semantico di ogni lemma è determinato dalla sua combinazione con argomenti e modificatori; d’altro lato la formalizzazione qui proposta rende evidente come ogni lemma possa agire sul significato degli altri in qualità di argomento, oppure di modificatore.
A destra delle Relazioni, e a quelle collegati, si dettagliano i Significati.
La marca d’uso, attribuita a ciascuna accezione del termine adotta le undici categorie impiegate nel GRADIT (per le sigle, vedi qui, alla sezione Strumenti, il campo Marche d’uso). Ma, poiché il punto di partenza e la prospettiva del lavoro sono quelle di Se questo è un uomo (nelle due edizioni del 1947 e del 1958), l’ambito di impiego della parola è ricavato anche dalle indicazioni di dizionari coevi al libro d’esordio di Levi, con risultati che possono differire da quelli del GRADIT. Di dislivelli significativi si dà conto nelle Note che, quando opportuno, si inseriscono per discutere questioni di particolare interesse o complessità.
Seguono i Contesti nei quali si collocano i lemmi. Per ogni occorrenza, la pericope non supera le dieci righe precedenti e le dieci seguenti la comparsa del lemma stesso, con un margine di elasticità che evita, nei limiti del possibile, di spezzare frasi di senso compiuto.