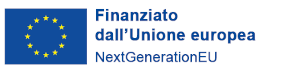Marche d’uso
Le parole di Primo Levi analizzate in questo Thesaurus sono accompagnate dalle relative marche d’uso.
Si è scelto di adottare le sigle fissate dal GRADIT 2007, ossia dal Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro,
con la collaborazione di Giulio C. Lepschy e Edoardo Sanguineti, Utet, Torino 2007² (la prima edizione era uscita nel 1999).
Alle marche del GRADIT è stata aggiunta una sola marca lì assente, quella che indica un neologismo (N).
L’attribuzione della marca è stata di volta in volta verificata anche su dizionari cronologicamente vicini all’opera in oggetto.
Si specifica che la marca d’uso verrà indicata per ogni singolo significato della parola in esamine.
Riprese dal GRADIT, ecco, in ordine alfabetico, sigle e descrizioni delle marche d’uso:
AD
di alta disponibilità; sono così marcati i vocaboli, relativamente rari nel parlare o scrivere, ma tutti ben noti perché legati ad atti e oggetti di grande rilevanza nella vita quotidiana (alluce, batuffolo, carrozzeria, dogana, ecc.).
AU
di alto uso; sono così marcati i vocaboli di alta frequenza, le cui occorrenze costituiscono un altro 6% circa delle occorrenze lessicali nell’insieme di tutti i testi scritti o discorsi parlati.
BU
di basso uso; sono così marcati vocaboli rari, tuttavia circolanti ancora con qualche frequenza in testi e discorsi del Novecento.
CO
comune; sono così marcati i vocaboli che sono usati e compresi indipendentemente dalla professione o mestiere che si esercita o dalla collocazione regionale e che sono generalmente noti a chiunque abbia un livello medio-superiore di istruzione.
DI
dialettale; sono così marcati vocaboli avvertiti come dialettali e circolanti in quanto tali in testi e discorsi italiani, con indicazione abbreviata del dialetto.
ES
esotismo; sono così marcati vocaboli avvertiti come stranieri, fonologicamente non adattati e non inseriti nella morfologia italiana, con indicazione abbreviata della lingua d’origine.
FO
fondamentale; tra i lemmi principali, sono così marcati i vocaboli di altissima frequenza, le cui occorrenze costituiscono circa il 90% delle occorrenze lessicali nell’insieme di tutti i testi scritti o discorsi parlati.
LE
di uso solo letterario; sono vocaboli usati nei testi canonici della tradizione letteraria e noti a chi ha più dimestichezza con essa. Si considerano canonici i seguenti autori dal Trecento al primo Novecento: Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano, Ariosto, Tasso, Machiavelli, Parini, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Croce.
N
sono così marcate le innovazioni che coinvolgono la forma della parola attraverso processi di derivazione o di combinazione; e i neologismi semantici, che coinvolgono parole già esistenti impiegate in una accezione nuova.
OB
obsoleto; sono così marcati vocaboli obsoleti e tuttavia presenti in vocabolari molto diffusi.
RE
regionale; sono vocaboli, in parte, ma non necessariamente, di provenienza dialettale, usati soprattutto in una delle varietà regionali dell’italiano, specificate di seguito in forma abbreviata.
TS
tecnico-specialistico; sono così marcati vocaboli legati a un uso marcatamente o esclusivamente tecnico o scientifico e noti soprattutto in rapporto a particolari attività, tecnologie, scienze. La marca TS è seguita dalla specificazione, in genere abbreviata, dell’ambito specialistico al quale si riferisce (es. med., mus., arte, ecc.); se un vocabolo è usato in più ambiti tecnicospecialistici, alla marca si fanno seguire le diverse specificazioni, separate tra loro da una virgola (es. med., farm.).
Nota bene: se un vocabolo appartiene a una fase della storia passata di una tecnica o di una disciplina, l’abbreviazione dell’ambito è preceduta da “st.” (= storia): per es. “st.ling.” (= storia della linguistica), “st.med.” (= storia della medicina).
Infine, per vocaboli che sono termini di discipline quali la botanica, la zoologia, l’ittiologia, l’ornitologia e l’entomologia, ma non identificano una categoria tassonomica e rappresentano la denominazione di una specie animale o vegetale, all’etichetta specialistica è stata aggiunta l’abbreviazione “com.”, per indicare che tale termine può avere una certa diffusione anche nel linguaggio comune, per es. “bot.com.” (= termine comune di botanica), “zool.com.” (= termine comune di zoologia).